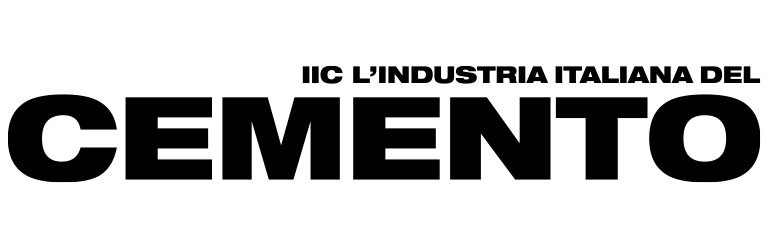La bella faccia del cemento

— La bella faccia del cemento: in inglese la traduzione di cemento a facciavista è “fair-faced concrete”. Tra i tanti significati di “fair” c’è proprio “bello” (“a fair afternoon” è un pomeriggio di bel tempo, “a fair maiden” una bella fanciulla). È indubbio che il cemento, dopo aver affascinato dagli anni cinquanta agli anni settanta del Novecento intere generazioni di progettisti brutalisti per il suo carattere grezzo e rude, ha conquistato quelle più giovani grazie alla sua “bella faccia”. E la sperimentazione del nuovo millennio ha svelato potenzialità inesauribili del materiale: setoso, colorato, elegante, scintillante.
Fino alla Seconda Guerra Mondiale, tranne che nelle grandi strutture e in poche altre esperienze – come quelle fondamentali di Perret – le potenzialità espressive superficiali del cemento armato non sono state sfruttate direttamente: intonacato come le murature o camuffato dietro sottili lastre di marmo, il materiale è stato considerato come un dispositivo statico con cui sovvertire i tradizionali rapporti tra pieni e vuoti. Il processo di rivelazione dei metodi costruttivi avviato invece nell’immediato dopoguerra prende forza proprio nel trattamento brutalista riservato al conglomerato. Il neorealismo porta a spogliare il cemento armato dei rivestimenti lapidei, degli intonaci, di tutti gli strati protettivi e a esibire il conglomerato nudo, a vista, con bene impresse sulla superficie le venature delle casseforme usate per sagomarlo. Passando da Le Corbusier, a Kahn, a Scarpa e, a tappe forzate, fino a Tadao Ando (maestro cui in questo numero è dedicato un omaggio), progressivamente il cemento armato assume un nuovo ruolo trasformandosi da materiale per strutture a materiale per superfici.

Protagonisti di questa nuova immagine architettonica sono i muri, che prendono il posto delle colonne cui l’affermazione del telaio ha ormai rubato “il carattere sacrale, il ritmo” (come dice Ando). Muri con ben incise le tracce della loro realizzazione, nella quale si combinano abilità artigianale e tecnologia moderna.
Ai gusci e alle piastre scabre e ruvide di Le Corbusier si contrappongono i lisci e satinati muri di Kahn, gettati tra casseforme di compensato dove, oltre al segno marcato dei giunti, spiccano le cavità lasciate dai distanziatori, debitamente ingigantite mediante tamponi di legno, accuratamente apposti alle due estremità del distanziatore, e poi riempite di piombo fino a qualche millimetro dalla superficie. Nelle sagome minutamente scalettate di Scarpa l’immagine monolitica del getto, fluidificato mediante additivi innovativi, è ottenuta con accuratissime casseforme, spesso costituite da morali di legno selezionato e assemblato con precisione da ebanista. Anche i muri astratti e monocromatici di Ando sono frutto di un’accorta fattura delle casseforme di legno laccato, opera di carpentieri non certo ordinari, ma anche di una studiata alchimia nel dosaggio degli inerti e dell’acqua, alla ricerca di uno slump modesto, capace di garantire getti consistenti e stabili.
E le nuove generazioni, quelle che hanno cominciato a lavorare alla fine del secolo o addirittura nel nuovo millennio, continuamente spostano in alto l’asticella della sperimentazione, in cerca di un’immagine sempre più pregiata, cangiante, pastosa, lussuosa ma anche semplice, essenziale, raffinata. Così ecco il cemento spirituale della Chiesa di Benedetta Tagliabue, quello carico di memoria di San Rossore 1938 e del Mausoleo di Michniow, quello che evoca il porfido rosso locale della Scuola di Musica di Bressanone di Carlana Mezzalira Pentimalli (cui è dedicata la nostra copertina e la rielaborazione grafica di Paolo Metaldi) e quello bianco madreperla della scuola di Marsiglia, quello camaleontico che sembra legno della casa di accoglienza di Anierès, quello liscio ed elegante di Renzo Piano a Los Angeles e di Steven Holl a Shangai, quello estruso nel laboratorio futurista di Philippe Block. E poi la sperimentazione recente della Scuola cinese, che del cemento a facciavista ha fatto il cuore della sua ricerca compositiva e che il cemento lo impasta con l’inchiostro di china, lo tatua imprimendo sulla superficie canne di bambù, lo mescola con materiali edilizi di risulta, lo fa assomigliare alla roccia e lo tratta come un materiale da scolpire con lo scalpello. Insomma, il cemento non finisce mai di stupire, al punto di aver sollecitato la fantasia di un regista visionario come Wes Anderson che nel suo ultimo film, in un tripudio di materia e colori, dedica un intero episodio al “Capolavoro di cemento”.!
Testo di Tullia Iori